simbologia ermetica della Balena Bianca:
Moby Dick
Anche i libri hanno un’anima, una vita segreta fatta di suoni, di odori, di parole. Il libro ci parla con un linguaggio per molti versi arcano, il cui mistero risiede in quella strana energia che pare provenire dal suo cuore cartaceo. Un cuore che palpita, pulsa, ci fa sorridere, arrabbiare o terrorizzare, ma che sempre ci cattura e ci affascina. Moby Dick è uno di questi. Fin da piccolo mi ha soggiogato, stregato. Ma ciò che più importa è che questo fantastico libro non scaturisce dalla fantasia del grande Melville, in realtà il romanzo si basa su un storia realmente accaduta. Una storia che non è semplicemente un evento autentico, c’è di più.
Dietro le vicende di uomini e cose si cela un significato più profondo, la cui trama sottile si snoda nei recessi profondi e terribili dell’essere umano dove risiede la sua parte più oscura e insondabile. E, inoltre, è un evento che ci parla della vendetta di una natura violata in nome della ricchezza.
La vera storia della balena bianca si svolse in una piccola cittadina di nome Nantucket, un villaggio sito su una dolce collinetta costellata di case e sormontata di mulini a vento, come spiega lo scrittore Nathaniel Philbrick nel suo libro Nel Cuore dell’Oceano, che narra le vicende che hanno ispirato Herman Melville, un uomo che odiava lo sterminio dei capodogli in nome di un benessere macchiato di sangue. La comunità di Nantucket era composta da circa settemila abitanti, per la maggior parte timorati di dio e appartenenti alla setta religiosa dei quaccheri, che praticavano la non violenza e allo stesso tempo facevano strage di balene. Giustificavano questa contraddizione citando le Sacre Scritture che affermavano la supremazia degli uomini sui pesci del mare, come se le balene fossero delle prede e non già degli esseri straordinari: “Tu hai, o Signore, creato la possente balena, quel  mirabile mostro dalla prodigiosa lunghezza; immensi sono la sua testa e il suo corpo, immensa la sua coda, inconcepibile la sua smisurata forza. Ma, eterno Dio, tu hai ordinato che noi, poveri deboli mortali, attacchiamo per mantenere noi stessi, le nostre mogli e i nostri figli, questo terribile mostro dalla furia marziale”. Questi versi furono composti da Peleg Folder, un baleniere di Nantucket divenuto un dignitario quacchero. Dietro l’aspetto bonario del villaggio si nascondeva al contrario, una ferocia inaudita e una assurda sete di sangue, come testimoniano le seguenti parole, un’invocazione utilizzata alla stregua di un brindisi e diretta verso amici, conoscenti o stranieri, anche se questi ultimi, a dire la verità, non erano molto amati e ben visti: “Morte ai viventi, lunga vita agli uccisori, successo alle mogli dei marinai e oleosa fortuna ai balenieri”. Queste persone erano convinte di appartenere ad una casta privilegiata che faceva capo alla setta dei quaccheri. Il film su Moby Dick, interpretato da Gregory Pech che impersonava il terribile capitano Achab, ci mostra dei poveri pescatori affamati e costretti ad uccidere le balene per riuscire a sopravvivere. La verità è che grazie alla spietata caccia agli immensi cetacei, la ricchezza e il benessere erano ormai parte integrante di Nantucket, un luogo divenuto un impero finanziario che nel 1775 veniva definito dallo statista inglese Edmund Burke, il posto dove risiedeva una nuova stirpe americana il cui successo nella caccia alle balene aveva superato la potenza collettiva di tutta l’Europa. Tutto sembrava filare liscio come l’olio fino a quel maledetto 23 febbraio 1821, quando la baleniera Dauphin, salpata pochi mesi prima per cacciare le grandi creature marine e riempire le stive d’olio, fece una scoperta spaventosa. La vedetta avvistò qualcosa di insolito. Il capitano della nave, il trentasettenne Zimri Coffin, puntò il cannocchiale e scorse la lancia di una baleniera diversa da qualunque altra avesse mai visto. Le fiancate erano rialzate di circa 15 centimetri, la prua, lunga sette metri e mezzo, era identica alla poppa. Due alberi di fortuna l’avevano trasformata in una rudimentale goletta. Le vele, incrostate dal sale e rese bianche dal Sole, le avevano permesso in qualche maniera, di percorrere parecchie miglia. Al timone non c’era nessuno: sembrava un’imbarcazione fantasma. Coffin si voltò verso il nocchiero e ordinò di accostare. Il timoniere obbedì, seguito dallo sguardo attento del capitano che controllava la manovra di avvicinamento alla malconcia scialuppa. La scena che si presentò ai loro occhi si sarebbe impressa nelle loro menti per il resto della vita. Videro delle ossa umane sparse sui traversini e sulle tavole di legno, quasi fosse la tana di un feroce e spaventoso mostro antropofago. Poi, gradualmente, intravidero due uomini. Erano rannicchiati alle estremità opposte della barca. La pelle, arsa dal Sole, era coperta di piaghe, le barbe
mirabile mostro dalla prodigiosa lunghezza; immensi sono la sua testa e il suo corpo, immensa la sua coda, inconcepibile la sua smisurata forza. Ma, eterno Dio, tu hai ordinato che noi, poveri deboli mortali, attacchiamo per mantenere noi stessi, le nostre mogli e i nostri figli, questo terribile mostro dalla furia marziale”. Questi versi furono composti da Peleg Folder, un baleniere di Nantucket divenuto un dignitario quacchero. Dietro l’aspetto bonario del villaggio si nascondeva al contrario, una ferocia inaudita e una assurda sete di sangue, come testimoniano le seguenti parole, un’invocazione utilizzata alla stregua di un brindisi e diretta verso amici, conoscenti o stranieri, anche se questi ultimi, a dire la verità, non erano molto amati e ben visti: “Morte ai viventi, lunga vita agli uccisori, successo alle mogli dei marinai e oleosa fortuna ai balenieri”. Queste persone erano convinte di appartenere ad una casta privilegiata che faceva capo alla setta dei quaccheri. Il film su Moby Dick, interpretato da Gregory Pech che impersonava il terribile capitano Achab, ci mostra dei poveri pescatori affamati e costretti ad uccidere le balene per riuscire a sopravvivere. La verità è che grazie alla spietata caccia agli immensi cetacei, la ricchezza e il benessere erano ormai parte integrante di Nantucket, un luogo divenuto un impero finanziario che nel 1775 veniva definito dallo statista inglese Edmund Burke, il posto dove risiedeva una nuova stirpe americana il cui successo nella caccia alle balene aveva superato la potenza collettiva di tutta l’Europa. Tutto sembrava filare liscio come l’olio fino a quel maledetto 23 febbraio 1821, quando la baleniera Dauphin, salpata pochi mesi prima per cacciare le grandi creature marine e riempire le stive d’olio, fece una scoperta spaventosa. La vedetta avvistò qualcosa di insolito. Il capitano della nave, il trentasettenne Zimri Coffin, puntò il cannocchiale e scorse la lancia di una baleniera diversa da qualunque altra avesse mai visto. Le fiancate erano rialzate di circa 15 centimetri, la prua, lunga sette metri e mezzo, era identica alla poppa. Due alberi di fortuna l’avevano trasformata in una rudimentale goletta. Le vele, incrostate dal sale e rese bianche dal Sole, le avevano permesso in qualche maniera, di percorrere parecchie miglia. Al timone non c’era nessuno: sembrava un’imbarcazione fantasma. Coffin si voltò verso il nocchiero e ordinò di accostare. Il timoniere obbedì, seguito dallo sguardo attento del capitano che controllava la manovra di avvicinamento alla malconcia scialuppa. La scena che si presentò ai loro occhi si sarebbe impressa nelle loro menti per il resto della vita. Videro delle ossa umane sparse sui traversini e sulle tavole di legno, quasi fosse la tana di un feroce e spaventoso mostro antropofago. Poi, gradualmente, intravidero due uomini. Erano rannicchiati alle estremità opposte della barca. La pelle, arsa dal Sole, era coperta di piaghe, le barbe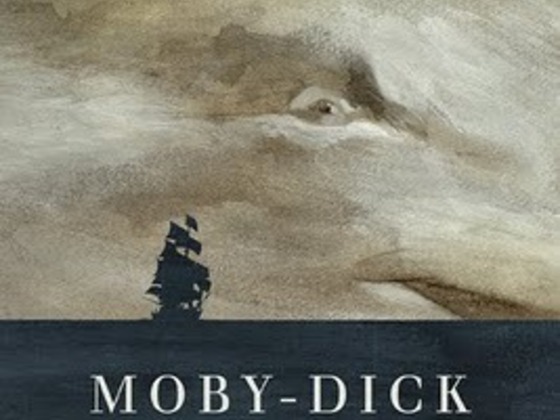 incrostate di sangue e lo sguardo perso nel vuoto esprimeva orrore. I due naufraghi erano intenti a succhiare il midollo delle ossa dei compagni morti. Stringevano avidamente quelle ossa rosicchiate e consunte e non permisero ai loro soccorritori di sottrargliele. Più tardi, quando il delirio che li aveva assaliti si stava diradando gettarono via quelle ossa inquietanti, sintomo di una follia contagiosa, si rifocillarono e decisero di raccontare cosa era accaduto. Si trattava di una storia dai contorni orripilanti, un incubo nel quale la barca, in balia delle onde, priva di acqua e di cibo, era miracolosamente scampata a un tragico e assurdo evento: una balena vendicativa e furba quanto un uomo che li aveva assaliti. Si erano salvati solo in otto, gli altri erano tutti morti. Questa è la vera vicenda che ispirò Melville e altri scrittori, la baleniera andata distrutta invece, si chiamava Essex. Fu uno dei disastri nautici più famosi e conosciuti del XIX secolo. Questa sciagura era talmente celebre che quasi ogni bambino americano ne leggeva un resoconto a scuola. Fu la scena clou che lo scrittore utilizzò per il suo romanzo. Ma il punto in cui termina l’avventura scritta da Melville, l’affondamento della nave, fu solo il principio per l’Essex, il peggio, infatti, doveva ancora accadere. Il capitano dell’Essex si chiamava Gorge Pollard Jr., un giovane di 28 anni, ma con una solida esperienza nonostante la fresca nomina al grado che ricopriva. Giunto nel mezzo dell’oceano, l’equipaggio si rese conto che una furiosa tempesta si stava avvicinando rendendo il mare nero come il catrame e agitato come un branco di bufali. La Essex rischiò di affondare, si inclinò pericolosamente, mentre un vento impetuoso soffiava con una forza tremenda e la scuoteva come un fuscello. Era piegata di ben 90 gradi e i lampi squarciavano il cielo illuminando l’acqua e il ponte. Finalmente i pennoni uscirono dal mare e la nave si drizzò con uno scatto. Ora che il pericolo era in
incrostate di sangue e lo sguardo perso nel vuoto esprimeva orrore. I due naufraghi erano intenti a succhiare il midollo delle ossa dei compagni morti. Stringevano avidamente quelle ossa rosicchiate e consunte e non permisero ai loro soccorritori di sottrargliele. Più tardi, quando il delirio che li aveva assaliti si stava diradando gettarono via quelle ossa inquietanti, sintomo di una follia contagiosa, si rifocillarono e decisero di raccontare cosa era accaduto. Si trattava di una storia dai contorni orripilanti, un incubo nel quale la barca, in balia delle onde, priva di acqua e di cibo, era miracolosamente scampata a un tragico e assurdo evento: una balena vendicativa e furba quanto un uomo che li aveva assaliti. Si erano salvati solo in otto, gli altri erano tutti morti. Questa è la vera vicenda che ispirò Melville e altri scrittori, la baleniera andata distrutta invece, si chiamava Essex. Fu uno dei disastri nautici più famosi e conosciuti del XIX secolo. Questa sciagura era talmente celebre che quasi ogni bambino americano ne leggeva un resoconto a scuola. Fu la scena clou che lo scrittore utilizzò per il suo romanzo. Ma il punto in cui termina l’avventura scritta da Melville, l’affondamento della nave, fu solo il principio per l’Essex, il peggio, infatti, doveva ancora accadere. Il capitano dell’Essex si chiamava Gorge Pollard Jr., un giovane di 28 anni, ma con una solida esperienza nonostante la fresca nomina al grado che ricopriva. Giunto nel mezzo dell’oceano, l’equipaggio si rese conto che una furiosa tempesta si stava avvicinando rendendo il mare nero come il catrame e agitato come un branco di bufali. La Essex rischiò di affondare, si inclinò pericolosamente, mentre un vento impetuoso soffiava con una forza tremenda e la scuoteva come un fuscello. Era piegata di ben 90 gradi e i lampi squarciavano il cielo illuminando l’acqua e il ponte. Finalmente i pennoni uscirono dal mare e la nave si drizzò con uno scatto. Ora che il pericolo era in  parte cessato, le vele vennero ridotte allo scopo di evitare altri guai. I danni, comunque, rivestivano una certa serietà: diverse vele, tra cui il velaccio e il coltellaccio, erano ridotte in brandelli, mentre le due lance appese accanto alla fiancata di babordo erano state strappate dalle rispettive gru e spazzate via con tutta la loro attrezzatura. Anche la scialuppa di riserva sita a poppa, era stata sfondata. Il resoconto lasciato dal mozzo Thomas Nickerson, uno dei sopravvissuti, era molto circostanziato, non romanzato e maledettamente reale. Nonostante il capitano era incline a ritornare verso Nantuket per le necessarie riparazioni, il suo primo ufficiale Owen Chase si oppose e suggerì di proseguire il viaggio. Egli era convinto che avrebbero potuto reperire delle scialuppe di riserva nelle Azzorre. Il secondo ufficiale, Matthew Joy, concordava con Chase e anche se su una nave, di norma, il volere del capitano è legge, Pollard decise di ascoltare i due e di continuare sulla rotta prevista, del resto questo era il suo primo incarico veramente importante. Molti marinai consideravano di cattivo auspicio il rovesciamento dell’Essex, il loro stato d’animo si fece tetro e gli uomini divennero scontrosi, anche a causa del cattivo trattamento ricevuto dagli ufficiali. Una volta tornati non si sarebbero più imbarcati sulla baleniera, questo i due ufficiali lo sapevano, per tale ragione avevano insistito per andare avanti. Era difficile reperire una nuova ciurma se fossero rientrati a Nantuket. Dopo un periodo di sfortuna, finalmente la stiva dell’Essex iniziò a riempirsi di barili d’olio ricavato dalle balene uccise. I barili erano all’incirca 700, quasi la metà del carico. Giunsero infine alle isole Galapagos, note anche con il nome di Encantadas, che in lingua spagnola significa, incantate o stregate. Intorno al 1840 e il 1850, Herman Melville rimase affascinato e colpito da queste isole e scrisse una serie di profili intitolata Le Isole Incantate. Secondo lo scrittore c’era qualcosa di non umano nelle Galapagos che definì: “Un luogo dove non si verificano mai cambiamenti”, alludendo alla loro inabitabilità. Quando Charles Darwin, il celebre naturalista, visitò le Galapagos nel 1835 a bordo della Beagle, notò che le tartarughe di ciascuna isola erano diverse dalle altre, specialmente nel colore, nella forma e nel guscio. Quattro giorni dopo, il 20 novembre del 1820, a più di 1500 miglia nautiche a ovest delle Galapagos e a sole 40 miglia a sud dell’equatore, la vedetta avvistò degli zampilli. Una volta giunti a circa mezzo miglio di distanza dal branco, i due guardianavi puntarono l’Essex in direzione del vento e tre lance vennero calate in mare. Inseguirono una balena, ma questa li scaraventò in acqua con un colpo di coda e una delle lance venne distrutta. Mentre gli uomini e il primo ufficiale, Owen Chase, stavano tornando verso l’Essex con la lancia superstite, il mozzo Thomas Nichkerson (allora aveva 15 anni), che in quella particolare occasione si trovava al timone della baleniera, notò qualcosa di sconvolgente. Al di là della prua di babordo un enorme capodoglio, il più grande che avessero mai visto fino ad allora, un maschio lungo circa 26 metri e del peso approssimativo di 80 tonnellate, distante un centinaio di metri dalla nave, si dirigeva verso di loro. Era talmente vicino che riuscirono a vedere l’immensa testa smussata e solcata da numerose cicatrici. Non era solo grande, ma si comportava anche in modo strano, infatti, invece di fuggire in preda al panico, solcava tranquillamente la superficie dell’acqua soffiando occasionalmente dallo sfiatatoio. Il mozzo ebbe l’impressione che il gigante li stesse fissando. Dopo due o tre zampilli si immerse, per poi riaffiorare a meno di 35 metri di distanza dall’Essex: “Al principio Chase non lo considerò una minaccia. Il suo aspetto e attaggiamento non destò allarme”, scriverà Nichkerson. Improvvisamente però, il capodoglio iniziò a muoversi. La sua coda, larga sei metri, andava su e giù, dapprima lentamente con una lieve oscillazione orizzontale, poi sempre più veloce e le onde formarono delle creste attorno alla sua gigantesca testa. Si scagliò contro la baleniera. Chase urlò a Nichkerson: “Tutto a dritta!”, sperava così di evitare la collisione, ma subito dopo si udì uno schianto pauroso: il capodoglio colpì la nave accanto alla catena dell’ancora di ormeggio posta a prua. L’Essex tremò violentemente e gli uomini vennero catapultati a terra. Il terrore era notevole, una cosa del genere non era mai accaduta prima; mai un capodoglio aveva attaccato una baleniera. Dopo la collisione il mostro passò sotto la nave colpendo lo scafo con tale forza da spaccare il sottochiglia, un solidissimo strato di legno spesso 15-20 centimetri. Riemerse come intontito, e dopo meno di un minuto il grande maschio di 80 tonnellate si risvegliò dal torpore prodotto dall’urto e iniziò ad aprire e serrare di scatto la mascella e a sferzare
parte cessato, le vele vennero ridotte allo scopo di evitare altri guai. I danni, comunque, rivestivano una certa serietà: diverse vele, tra cui il velaccio e il coltellaccio, erano ridotte in brandelli, mentre le due lance appese accanto alla fiancata di babordo erano state strappate dalle rispettive gru e spazzate via con tutta la loro attrezzatura. Anche la scialuppa di riserva sita a poppa, era stata sfondata. Il resoconto lasciato dal mozzo Thomas Nickerson, uno dei sopravvissuti, era molto circostanziato, non romanzato e maledettamente reale. Nonostante il capitano era incline a ritornare verso Nantuket per le necessarie riparazioni, il suo primo ufficiale Owen Chase si oppose e suggerì di proseguire il viaggio. Egli era convinto che avrebbero potuto reperire delle scialuppe di riserva nelle Azzorre. Il secondo ufficiale, Matthew Joy, concordava con Chase e anche se su una nave, di norma, il volere del capitano è legge, Pollard decise di ascoltare i due e di continuare sulla rotta prevista, del resto questo era il suo primo incarico veramente importante. Molti marinai consideravano di cattivo auspicio il rovesciamento dell’Essex, il loro stato d’animo si fece tetro e gli uomini divennero scontrosi, anche a causa del cattivo trattamento ricevuto dagli ufficiali. Una volta tornati non si sarebbero più imbarcati sulla baleniera, questo i due ufficiali lo sapevano, per tale ragione avevano insistito per andare avanti. Era difficile reperire una nuova ciurma se fossero rientrati a Nantuket. Dopo un periodo di sfortuna, finalmente la stiva dell’Essex iniziò a riempirsi di barili d’olio ricavato dalle balene uccise. I barili erano all’incirca 700, quasi la metà del carico. Giunsero infine alle isole Galapagos, note anche con il nome di Encantadas, che in lingua spagnola significa, incantate o stregate. Intorno al 1840 e il 1850, Herman Melville rimase affascinato e colpito da queste isole e scrisse una serie di profili intitolata Le Isole Incantate. Secondo lo scrittore c’era qualcosa di non umano nelle Galapagos che definì: “Un luogo dove non si verificano mai cambiamenti”, alludendo alla loro inabitabilità. Quando Charles Darwin, il celebre naturalista, visitò le Galapagos nel 1835 a bordo della Beagle, notò che le tartarughe di ciascuna isola erano diverse dalle altre, specialmente nel colore, nella forma e nel guscio. Quattro giorni dopo, il 20 novembre del 1820, a più di 1500 miglia nautiche a ovest delle Galapagos e a sole 40 miglia a sud dell’equatore, la vedetta avvistò degli zampilli. Una volta giunti a circa mezzo miglio di distanza dal branco, i due guardianavi puntarono l’Essex in direzione del vento e tre lance vennero calate in mare. Inseguirono una balena, ma questa li scaraventò in acqua con un colpo di coda e una delle lance venne distrutta. Mentre gli uomini e il primo ufficiale, Owen Chase, stavano tornando verso l’Essex con la lancia superstite, il mozzo Thomas Nichkerson (allora aveva 15 anni), che in quella particolare occasione si trovava al timone della baleniera, notò qualcosa di sconvolgente. Al di là della prua di babordo un enorme capodoglio, il più grande che avessero mai visto fino ad allora, un maschio lungo circa 26 metri e del peso approssimativo di 80 tonnellate, distante un centinaio di metri dalla nave, si dirigeva verso di loro. Era talmente vicino che riuscirono a vedere l’immensa testa smussata e solcata da numerose cicatrici. Non era solo grande, ma si comportava anche in modo strano, infatti, invece di fuggire in preda al panico, solcava tranquillamente la superficie dell’acqua soffiando occasionalmente dallo sfiatatoio. Il mozzo ebbe l’impressione che il gigante li stesse fissando. Dopo due o tre zampilli si immerse, per poi riaffiorare a meno di 35 metri di distanza dall’Essex: “Al principio Chase non lo considerò una minaccia. Il suo aspetto e attaggiamento non destò allarme”, scriverà Nichkerson. Improvvisamente però, il capodoglio iniziò a muoversi. La sua coda, larga sei metri, andava su e giù, dapprima lentamente con una lieve oscillazione orizzontale, poi sempre più veloce e le onde formarono delle creste attorno alla sua gigantesca testa. Si scagliò contro la baleniera. Chase urlò a Nichkerson: “Tutto a dritta!”, sperava così di evitare la collisione, ma subito dopo si udì uno schianto pauroso: il capodoglio colpì la nave accanto alla catena dell’ancora di ormeggio posta a prua. L’Essex tremò violentemente e gli uomini vennero catapultati a terra. Il terrore era notevole, una cosa del genere non era mai accaduta prima; mai un capodoglio aveva attaccato una baleniera. Dopo la collisione il mostro passò sotto la nave colpendo lo scafo con tale forza da spaccare il sottochiglia, un solidissimo strato di legno spesso 15-20 centimetri. Riemerse come intontito, e dopo meno di un minuto il grande maschio di 80 tonnellate si risvegliò dal torpore prodotto dall’urto e iniziò ad aprire e serrare di scatto la mascella e a sferzare l’acqua con la coda. Era in preda ad una furia cieca e qualcuno gridò: “ Eccolo, sta puntando di nuovo verso di noi”. Con una velocità pari a sei nodi, il doppio di quella iniziale, la baleniera di 238 tonnellate scricchiolò paurosamente e la nave cominciò ad imbarcare acqua. Le scialuppe di salvataggio furono calate in mare, l’Essex ormai stava affondando ghermita dagli abissi nel cui fondo si trovavano catene montuose di grandi dimensioni e profondi canyon. Era come se la natura, più volte violata, si fosse voluta vendicare. Quel capodoglio aveva agito come un giustiziere che voleva riscattare tutte le balene massacrate senza pietà e pareggiare i conti con gli spietati balenieri. Questa idea, per quanto bizzarra, era passata per la mente anche al primo ufficiale Owen Chase, convinto che l’Essex e il suo equipaggio fossero rimasti vittime di un danno voluto e calcolato dal capodoglio, come scriverà in seguito, aggiungendo che un inspiegabile destino o disegno si era messo all’opera. Come se Qualcosa, forse Dio, si fosse impossessato dell’animale per misteriosi e insondabili scopi. Questo affermerà più volte Chase. Se anche altri capodogli avessero iniziato ad affondare le baleniere, col tempo la flottiglia di navi di Nantucket si sarebbe ridotta ad un ammasso di relitti galleggianti. Ecco come nacque l’idea di Melville, che in quel disastro aveva visto ancestrali richiami, ombre e simbolismi arcani.
l’acqua con la coda. Era in preda ad una furia cieca e qualcuno gridò: “ Eccolo, sta puntando di nuovo verso di noi”. Con una velocità pari a sei nodi, il doppio di quella iniziale, la baleniera di 238 tonnellate scricchiolò paurosamente e la nave cominciò ad imbarcare acqua. Le scialuppe di salvataggio furono calate in mare, l’Essex ormai stava affondando ghermita dagli abissi nel cui fondo si trovavano catene montuose di grandi dimensioni e profondi canyon. Era come se la natura, più volte violata, si fosse voluta vendicare. Quel capodoglio aveva agito come un giustiziere che voleva riscattare tutte le balene massacrate senza pietà e pareggiare i conti con gli spietati balenieri. Questa idea, per quanto bizzarra, era passata per la mente anche al primo ufficiale Owen Chase, convinto che l’Essex e il suo equipaggio fossero rimasti vittime di un danno voluto e calcolato dal capodoglio, come scriverà in seguito, aggiungendo che un inspiegabile destino o disegno si era messo all’opera. Come se Qualcosa, forse Dio, si fosse impossessato dell’animale per misteriosi e insondabili scopi. Questo affermerà più volte Chase. Se anche altri capodogli avessero iniziato ad affondare le baleniere, col tempo la flottiglia di navi di Nantucket si sarebbe ridotta ad un ammasso di relitti galleggianti. Ecco come nacque l’idea di Melville, che in quel disastro aveva visto ancestrali richiami, ombre e simbolismi arcani.
Herman Melville: un uomo, un’avventura
Melville nacque a New York nel 1819, di origine olandese da parte materna e bostoniana e calvinista da parte paterna, era il terzo di otto figli. Figura di primo piano nell’ambito della narrativa dell’Ottocento, dovette interrompere gli studi all’Accademia di Albany (1830-34), dopo la morte improvvisa del padre che lasciò la famiglia in condizioni economiche disastrose. Per questa ragione decise di imbarcarsi come mozzo sulla nave mercantile Highlander, diretta a Liverpool. Tornato in America si dedicò all’insegnamento dal 1837 al 1841, anno in cui si imbarcò sulla baleniera Acushnet, diretta verso i Mari del Sud, disertore dopo più di un anno, abbandonò la nave a Nakuhiva, nelle isole Marchesi (1842). Qui visse per quattro mesi tra i Taipi. Tornò di nuovo a New York e l’anno successivo si arruolò ancora una volta a Honolulu, su una nave da guerra. Seguirono altre avventure per mare e anche sulla terraferma. Nel 1847 si sposò a Boston, si trasferì a New York e dopo un viaggio in Europa decise di stabilirsi con una certa assiduità (1850-65) in una fattoria vicino a Pittsfield, nel  Massachusetts. Viaggiò ancora in Europa e in Palestina e, più tardi, fu a San Francisco. Dal 1866 e fino alla morte avvenuta nel 1891, visse a New York. Tra i suoi lavori ricordiamo White Jacket, che narra la sua esperienza vissuta in guerra quando era a bordo della Nakuhiva; Taipi (Typee, a Peep at Poyinesian Life, 1846), che ebbe un grande successo come storia di vita vissuta, il romanzo descriveva la cultura complessa e raffinata dei popoli con cui l’autore era venuto in contatto nei Mari del Sud; Omoo (1847), un racconto d’avventure nei Mari del Sud; Mardi (1849) e ancora Redburn (1849, traduzione italiana La nave di vetro), un romanzo a sfondo autobiografico. Altre opere furono elaborate da Melville, la più celebre è senza dubbio il capolavoro Moby Dick, pubblicato nel 1851. Questo romanzo epico si snoda in un mare biblico e allo stesso tempo omerico dove il richiamo alle prove iniziatiche è palese. Un lavoro dai contorni apocalittici, il cui riferimento all’opera di Giovanni l’Evangelista non è casuale, Moby Dick scandaglia le regioni segrete e oscure celate nella mente dell’uomo.
Massachusetts. Viaggiò ancora in Europa e in Palestina e, più tardi, fu a San Francisco. Dal 1866 e fino alla morte avvenuta nel 1891, visse a New York. Tra i suoi lavori ricordiamo White Jacket, che narra la sua esperienza vissuta in guerra quando era a bordo della Nakuhiva; Taipi (Typee, a Peep at Poyinesian Life, 1846), che ebbe un grande successo come storia di vita vissuta, il romanzo descriveva la cultura complessa e raffinata dei popoli con cui l’autore era venuto in contatto nei Mari del Sud; Omoo (1847), un racconto d’avventure nei Mari del Sud; Mardi (1849) e ancora Redburn (1849, traduzione italiana La nave di vetro), un romanzo a sfondo autobiografico. Altre opere furono elaborate da Melville, la più celebre è senza dubbio il capolavoro Moby Dick, pubblicato nel 1851. Questo romanzo epico si snoda in un mare biblico e allo stesso tempo omerico dove il richiamo alle prove iniziatiche è palese. Un lavoro dai contorni apocalittici, il cui riferimento all’opera di Giovanni l’Evangelista non è casuale, Moby Dick scandaglia le regioni segrete e oscure celate nella mente dell’uomo.
Ombre dal profondo: valori ermetici della balena bianca
L’eterna lotta tra bene e male emerge con forza dal libro di Melville. L’antico ciclo dell’ombra e della luce che si rincorrono senza mai completarsi, i demoni interiori, le tenebre e la natura nascosta dell’essere umano sono magistralmente tratteggiati in quest’opera dalle valenze esoteriche. La lotta col terribile guardiano della soglia, custode della Conoscenza, appare più che mai chiaro, così come è evidente la battaglia con le forze bestiali insite nella natura umana, che vanno sedate e vinte allo scopo di fare risvegliare l’uomo-dio, o Adam Kadmon della tradizione cabalistica.
Har-Megiddo: lo scontro finale
L’aspetto epico connesso con il Moby Dick di Melville, come accennato racchiude delle analogie con l’Apocalisse di Giovanni. Un dramma cosmico, al cui interno interagiscono forze immani, dove il bene e il male si preparano per la battaglia finale. IL capitano Achab e la grande balena bianca sono i due poli di un magnete che esercitano eguale forza d’attrazione. Lo scontro finale che viene citato nell’Apocalisse, prende il nome della città di Har-Megiddo (Monte di Megiddo), situata a 90 chilometri a Nord di Gerusalemme, a Tell-el Mutesellin, nella valle di Izreel. Questo luogo viene chiamato nella Bibbia Armageddon. E’ qui che disputerà il giorno del giudizio, l’ultima battaglia dell’umanità. Allo stesso modo, lo scontro tra la balena e Achab allude a un duello tra positivo e negativo, tra luce e tenebre, Bene e Male. L’oceano nel quale si sta decidendo il destino del capitano e della terribile creatura rappresenta le acque primordiali, l’utero primigenio, il liquido o fluido astrale della Genesi. L’oceano è il caos che precede alla formazione delle forme stesse. Qui la battaglia infuria, ma non ci saranno ne vincitori ne vinti, perché Bene e Male sono complementari, l’uno non può esistere senza l’altro, così come al giorno segue sempre la notte. Achab colpirà a morte Moby Dick, ma verrà a sua volta trascinato nelle gelide profondità dell’oceano. Con il suo gesto, Achab genera la salvezza dell’umanità e ricaccia negli abissi i mali, la corruzione, l’odio e i demoni che proprio gli esseri umani hanno resi vitali. Si sacrifica per ristabilire un equilibrio a lungo alterato, un bene violato. In tutto questo si scorge anche un aspetto dalle valenze alchemiche, l’unione degli opposti dai quali nascerà il Rebis alchemico, l’Androgino ermetico. Dall’opera grandiosa di Melville traspare inoltre, una profonda spiritualità che permea le pagine del romanzo. Una spiritualità mai eccessiva o colma di fanatismo, ma piuttosto sacrale e interiore.
creatura rappresenta le acque primordiali, l’utero primigenio, il liquido o fluido astrale della Genesi. L’oceano è il caos che precede alla formazione delle forme stesse. Qui la battaglia infuria, ma non ci saranno ne vincitori ne vinti, perché Bene e Male sono complementari, l’uno non può esistere senza l’altro, così come al giorno segue sempre la notte. Achab colpirà a morte Moby Dick, ma verrà a sua volta trascinato nelle gelide profondità dell’oceano. Con il suo gesto, Achab genera la salvezza dell’umanità e ricaccia negli abissi i mali, la corruzione, l’odio e i demoni che proprio gli esseri umani hanno resi vitali. Si sacrifica per ristabilire un equilibrio a lungo alterato, un bene violato. In tutto questo si scorge anche un aspetto dalle valenze alchemiche, l’unione degli opposti dai quali nascerà il Rebis alchemico, l’Androgino ermetico. Dall’opera grandiosa di Melville traspare inoltre, una profonda spiritualità che permea le pagine del romanzo. Una spiritualità mai eccessiva o colma di fanatismo, ma piuttosto sacrale e interiore.
Achab e Moby Dick, come Jekyll e Mr. Hyde
Nel romanzo di Melville è possibile ravvisare quell’aspetto segreto che sta alla base dei conflitti interiori, che intercorrono tra la parte conscia e la parte inconscia. La bestia dormiente, che giace nei recessi della mente, e la parte consapevole, che mai eccede e sempre si controlla, sono le facce di una medesima medaglia. Si tratta dell’animale che ciascun essere umano porta dentro e che a volte, in maniera incomprensibile, emerge dagli abissi del cervello e ci fa compiere azioni esecrabili. Proprio come Mister Hyde. Non a caso, quando Jekyll viene ucciso, con lui muore anche Hyde. Allo stesso modo, quando la balena bianca s’inabissa, portando con se nel suo viaggio di morte l’intrepido Achab, tutti e due spariscono e muoiono, perché Achab e Moby Dick sono il volto di uno stesso individuo.
Essex: l’odissea continua…
Cosa era accaduto ai 20 uomini della Essex? Perché erano rimasti soltanto in otto? Dopo la perdita della baleniera l’equipaggio, suddiviso in base ad una rigorosa selezione che privilegiava i marinai nati a Nantucket, prese posto sulle lance che si avventurarono nelle vastità dell’oceano. A causa di una serie di decisioni errate prese dai due ufficiali, e per colpa del capitano che si era fatto sopraffare da questi ultimi scrollandosi di dosso le sue responsabilità, la rotta intrapresa li stava portando verso un mucchio di guai. Inoltre Chase, il primo ufficiale, era ossessionato dalla visione del grande capodoglio che li aveva speronati. Basandosi sul resoconto relativo agli incubi, che in seguito Chase avrebbe vergato, Melville si era ispirato per costruire il personaggio di Achab, un uomo che non  emerge mai dagli abissi psichici, proprio come Chase il quale era convinto che il capodoglio che li aveva gettati in mare rivelasse una crudeltà voluta, calcolata. Achab, in modo analogo, era tormentato dalla sensazione di oltraggiosa forza sostenuta da una imperscrutabile malvagità della balena bianca. Moby Dick era un simbolo, il simbolo del male e delle iniquità. Le provviste che gli uomini dell’Essex erano riusciti a recuperare dal relitto erano scarse e il pericolo di morire di inedia era in agguato. Per motivi di spazio non possiamo descrivere tutte le privazioni e i disagi che i naufraghi subirono, ma la
emerge mai dagli abissi psichici, proprio come Chase il quale era convinto che il capodoglio che li aveva gettati in mare rivelasse una crudeltà voluta, calcolata. Achab, in modo analogo, era tormentato dalla sensazione di oltraggiosa forza sostenuta da una imperscrutabile malvagità della balena bianca. Moby Dick era un simbolo, il simbolo del male e delle iniquità. Le provviste che gli uomini dell’Essex erano riusciti a recuperare dal relitto erano scarse e il pericolo di morire di inedia era in agguato. Per motivi di spazio non possiamo descrivere tutte le privazioni e i disagi che i naufraghi subirono, ma la  cosa più atroce che si stava profilando era costituita dagli episodi di cannibalismo che stavano per essere perpetrati. Ormai il cibo scarseggiava e le energie stavano scemando, così quando Lawoson Thomas, uno degli uomini, morì, ogni tabù venne infranto e l’orribile pasto fu consumato, anche se non fruttò gran che in quanto il loro compagno era notevolmente consunto. Poi fu la volta di Samuel Reed che una volta deceduto si trasformò in cibo per gli altri marinai. Si trattava di una cosa orribile, infatti, l’uomo veniva squartato e mangiato nell’angusto spazio offerto dalle scialuppe. Ora la situazione si era fatta ancora più disperata. I superstiti si guardavano l’un l’altro, sospettosi, pensando che potevano essere aggrediti nel sonno ed essere mangiati. Oltretutto, una delle imbarcazioni era scomparsa e nessuno l’aveva più vista. In seguito gli uomini decisero di “tirare a sorte” per stabilire chi di loro doveva essere ucciso per poi essere trangugiato. Quella di tirare a sorte era una pratica diffusa tra i marinai che rischiavano di morire di fame. Il primo caso documentato risale alla prima metà del XVII secolo, quando sette marinai inglesi salpati dall’isola caraibica di Saint Kitts, naufragarono durante una tempesta. Dopo 17 giorni uno di loro propose di tirare a sorte. Fu proprio lui ad essere sorteggiato, e una volta ripetuta la procedura per determinare chi doveva giustiziarlo, venne ucciso e mangiato. Gli uomini della Essex fecero lo stesso; uno di loro si trovò tra le mani il bastoncino più corto, si trattava di Owen Coffin, un giovane di Nantucket. Lasciò una lettera per sua madre nel caso che qualcuno fosse riuscito a tornare a casa, poi fu ucciso e… Si comprende adesso perché i due superstiti tratti in salvo stringevano e succhiavano ossa umane. Abbiamo volutamente omesso gli aspetti più atroci di tutta la vicenda.
cosa più atroce che si stava profilando era costituita dagli episodi di cannibalismo che stavano per essere perpetrati. Ormai il cibo scarseggiava e le energie stavano scemando, così quando Lawoson Thomas, uno degli uomini, morì, ogni tabù venne infranto e l’orribile pasto fu consumato, anche se non fruttò gran che in quanto il loro compagno era notevolmente consunto. Poi fu la volta di Samuel Reed che una volta deceduto si trasformò in cibo per gli altri marinai. Si trattava di una cosa orribile, infatti, l’uomo veniva squartato e mangiato nell’angusto spazio offerto dalle scialuppe. Ora la situazione si era fatta ancora più disperata. I superstiti si guardavano l’un l’altro, sospettosi, pensando che potevano essere aggrediti nel sonno ed essere mangiati. Oltretutto, una delle imbarcazioni era scomparsa e nessuno l’aveva più vista. In seguito gli uomini decisero di “tirare a sorte” per stabilire chi di loro doveva essere ucciso per poi essere trangugiato. Quella di tirare a sorte era una pratica diffusa tra i marinai che rischiavano di morire di fame. Il primo caso documentato risale alla prima metà del XVII secolo, quando sette marinai inglesi salpati dall’isola caraibica di Saint Kitts, naufragarono durante una tempesta. Dopo 17 giorni uno di loro propose di tirare a sorte. Fu proprio lui ad essere sorteggiato, e una volta ripetuta la procedura per determinare chi doveva giustiziarlo, venne ucciso e mangiato. Gli uomini della Essex fecero lo stesso; uno di loro si trovò tra le mani il bastoncino più corto, si trattava di Owen Coffin, un giovane di Nantucket. Lasciò una lettera per sua madre nel caso che qualcuno fosse riuscito a tornare a casa, poi fu ucciso e… Si comprende adesso perché i due superstiti tratti in salvo stringevano e succhiavano ossa umane. Abbiamo volutamente omesso gli aspetti più atroci di tutta la vicenda.
Un tempo Achab perse una gamba lottando contro Moby Dick. Ora vuole vendetta. Invece, tra i gorghi insanguinati dal mostro, troverà la grande pace.

