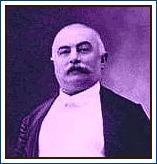Come dalla trama di un avvincente romanzo, affiora dagli atti di un clamoroso processo svoltosi in pieno regime fascista, una incredibile e inquietante realtà “occulta” che scuote la Roma e l’Italia “imperiali” ed esoteriche dell’epoca. La sentenza è chiara e definitiva ma la pubblicazione integrale nel 1942 della requisitoria della pubblica accusa e delle arringhe dei notissimi avvocati di parte in un volume dal titolo singolare e fortemente evocativo, “Il Processo del Mago”, alza il velo su episodi sconosciuti e verità nascoste, gravide di oscuri risvolti e imprevedibili sviluppi.
Molti interrogativi e segreti sollevati ed emersi dalla controversa inchiesta non sono stati ancora risolti né divulgati, ma un dato di fatto di valore oggettivo aggiunge una nota ulteriormente enigmatica al mistero che permea l’intero scenario: appena stampato, il libro scompare “inspiegabilmente” dalla circolazione, fino a divenire letteralmente introvabile, persino nei circuiti antiquari. Alcuni ipotizzano sia stato fatto sparire per evitare che una serie di sconcertanti rivelazioni e imbarazzanti confessioni divenissero di pubblico dominio. Da chi? Evidentemente da qualcuno che intendeva impedire la diffusione di notizie e informazioni incandescenti che avrebbero gettato un’ombra pesante sui personaggi impietosamente coinvolti in questo scandalo grandguignolesco, già definito Il Caso di Pandora, per esprimere con sardonica efficacia tutto ciò che di marcio e raccapricciante ne è scaturito. Si tratta in pratica di una tragica vicenda imperniata su una colossale quanto squallida truffa, perpetrata pro salute populi ai danni del barone Ricciardelli, un noto e facoltoso aristocratico appassionato di esoterismo, e consumata in un clima di torbidi inganni, miserie morali, grottesche menzogne e fatali illusioni. Intorno ad essa ruotano nella veste di protagonisti lo stesso Ricciardelli da una parte, e P.Pugliese, il nipote della maggiore figura rappresentativa dell’ermetismo magico italiano (G.Kremmerz, peraltro assolutamente estraneo ai fatti), dall’altra, mentre, nel ruolo di attive “comparse”, animano il palcoscenico alcuni tra i più alti esponenti degli stessi vertici della “Fratellanza di Miriam” (l’organismo iniziatico fondato dal Kremmerz medesimo), presidi di Accademie e stando a quanto il P.M. Polito de Rosa denuncia nel suo rovente j’accuse, avidi sciacalli di infima specie il cui operato sarà stigmatizzato in un monito lapidario che suona come un inappellabile verdetto: “Nessuno osi parlare di probità, rettitudine e dignità di vita, a proposito di costoro!”.